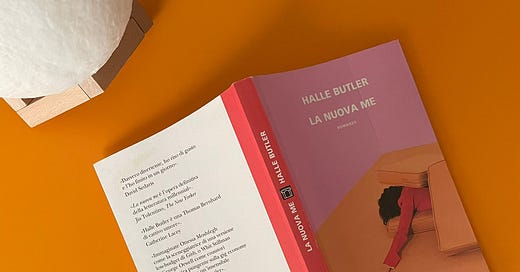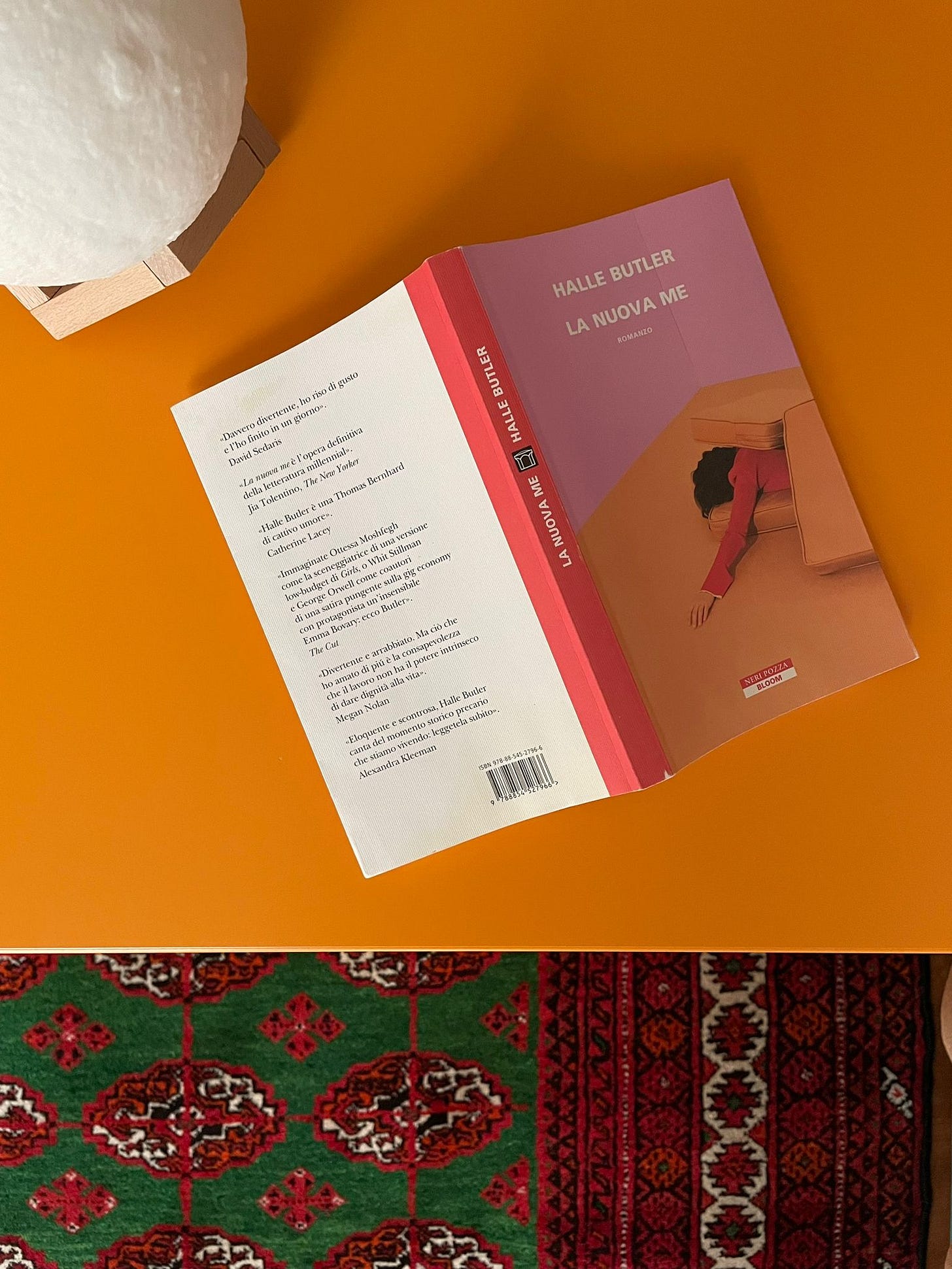Mi sono sentita spesso ripetere questa frase.
“Sei nel tuo tempo.”
Me l’hanno detta con fare saggio e rassicurante.
In realtà, ti stanno dicendo un’ovvietà, perché ognuno è nel proprio tempo — è quello che ha, ma è la sfumatura con cui la frase viene detta che vuole darle spessore.
Grazie al cielo, non è mai stata accompagnata da una pacca sulla spalla. Sarebbe stato troppo.
Ora che scrivo, penso alla frase “hai bucato una gomma” e le due mi sembrano estremamente (e pericolosamente) somiglianti. Ti dicono qualcosa che sai già, ma nello stesso tempo prospettandotela come la chiave della soluzione (ma è se hai o meno la gomma di scorta che fa la differenza).
Come tante altre ovvietà, al pari del “la salute è la prima cosa”, si tratta di una verità importante e le ancillari implicazioni che si porta dietro, paperelle più o meno smarrite, sono consigli preziosi che, spesso, nella nostra “stupidità umana” (essenziale alla sopravvivenza perché sennò, pensandoci, chi farebbe figli in questo mondo?) e nel nostro sempre considerarci “eccezioni e non regole”, non seguiamo.
La comprensione della routine di certi fenomeni ha reso possibile all’umanità di evolvere e la nostra vita è scandita da ricorrenze, il crescere lo è. Cresci e “sblocchi” delle tappe, il tuo stesso corpo lo fa. Questo ci permette di prevedere, se non tutto quello che accadrà, alcune cose e di prepararci, anche mentalmente. Ha una funzione rassicurante.
Dopo l’estate, si torna a scuola.
Prima di ciò, ci si può disperare, però; almeno, si può farlo con i propri compagni di classe: tra una lamentela e l’altra, ti confronti su che libri devi ancora acquistare, pensi a come vestirti “il primo giorno” e sai che ogni sera ti ritroverai a “preparare lo zaino per il giorno dopo”.
Ricordo che, al liceo, mi mettevo d’accordo con le mie compagne di banco su quali libri portare: essendo troppi, per evitare un peso eccessivo (almeno quello fisico, dai), ci “dividevamo” i manuali che avremmo poi potuto leggere insieme, durante le lezioni, il giorno dopo.
Un libro al centro tra i due banchi, le nostre teste vicine, la lezione in comune e gli occhi che percorrevano le stesse righe.
Non c’è niente che sia più diverso da questa immagine di un’altra, quella di quando a 30 anni ti ritrovi con i tuoi amici una sera a disquisire del più e del meno.
Al di fuori del tempo in cui la campanella scandiva le vostre vite, ognuno di voi si ritrova nel suo tempo: come cerchi che si intersecano, avete del tempo in comune con gli altri, lo passate anche, ma per il resto potreste anche trovarvi anni luce distanti.
Siamo tutti nel nostro tempo, è vero. Ma se in quel nostro tempo ci sentiamo da soli? Il lato “oscuro” del “sei nel tuo tempo” è che può essere solo tuo.
Un giorno soffi una candelina e diventi automaticamente proprietari* di un appartamento nel “condominio dei 30enni”. Non sei ancora nella sfera degli “-anta”, quindi, a parte ciò che ti fa pensare che spalmarti ogni sera il retinolo sul viso sia la panacea della tua sindrome di Peter Pan, hai ancora qualche speranza nel decennio avvenire — che questo rientri o meno nella “stupidità umana” di cui sopra non è dato sapere.
Poi, però, ti capita una “riunione di condominio” e ti ritrovi a domandarti se non hai sbagliato indirizzo, anche se il tuo cuore, magari, la residenza l’ha lì.
La distanza temporale è tanto più lunga quanto più sono gli intrecci di esperienze diverse che la intessono.
Così, potresti trovarti seduta ad ascoltare il piano per la riorganizzazione del giardino condominiale e renderti conto di non capire di cosa si stia parlando, perché in quel giardino non ci sei mai stata — come si accede?.
Non puoi neanche dire la tua opinione sul colore delle inferiate del balcone, perché tu non le hai. Né sei in grado di aiutare con la problematica di chi vive al piano terra, perché non abiti lì.
E qualcosa da dire l’avresti, ma sei fuori (quel) tempo, perché tutte le tue questioni erano in altri ordini del giorno, di anni prima, di altre riunioni condominiali dove tu c’eri, ma non c’eri davvero, perché eri nel tuo tempo, che non era il loro.
Una coppia di condomini ha portato con sé il loro bambino. È nel suo tempo, ma è anche nel suo mondo, perché è in quell’età dove il mondo e il tempo si mischiano tanto da poter essere la stessa cosa. Ti avvicini, state un po’ insieme, e uno dei suoi genitori ti sorride, dicendoti di stare attent* perché è “nella fase dei perché” e rischia di “sfinirti di domande”.
La cosa buffa è che sei anche tu, nella fase dei perché. Certo, diversa, ma pur sempre figlia dell’incertezza. In quel “condominio dei 30enni”, nel tuo appartamento, ti poni anche tu un sacco di domande — la tua mente la sera è un alveare. Domande che, però, non riguardano il giardino, il colore delle inferiate, il problema del piano terra.
Si tratta di condivisione, alla fine. Condivisione delle stesse incertezze, delle stesse domande. Degli stessi “perché”. Forse è questo che ci fa sentire meno soli.
A 30 anni l’immagine comune è che dovresti aver capito, se non tutto, le cose più importanti per dare una forma o direzione alla tua vita. Il tuo tempo non è più il tempo delle sperimentazioni. La crescita prevede altre tappe per te.
La vita, però, è tutt’altra cosa. E può capitare che non sia così.
Così, nel “condominio dei 30enni”, c’è Luca che sta cercando casa da comprare e una dentro di sé; c’è una coppia che si è appena sposata e una che non vede l’ora di farlo; c’è Matilde che vorrebbe lasciare tutto, ma non può lasciare il lavoro e Nora che, finalmente, ha trovato un motivo per restare; c’è chi sta trovando gioia nel progettare i prossimi passi e chi, invece, non sa quali fare. Chi, della stanza che ha libera, ne ha fatto una piccola palestra, chi la stanza per il proprio figlio, chi per ospitare tutti gli amici che lo vengono a trovare. C’è chi quella stanza non la sta creando o non ce l’ha.
C’è Amanda che sta spiegando ai propri genitori come proteggersi dalle truffe online e c’è chi vorrebbe poterlo ancora fare. Chi ha 30 anni, ma è come se ne avesse vissuti già 50 e chi ha appena iniziato a sperimentare. Margherita si è appena iscritta all’università, Paolo non si può permettere di porsi domande, Lidia ha appena firmato le carte del divorzio.
Tante finestre allo stesso numero civico, tante luci che si accendono e spengono a orari disallineati.
Cresciamo “sapendo cosa accadrà”, ma in realtà pensiamo di saperlo. Così come gli adulti dicono ai bambini “quando sarai grande capirai”, pur sapendo che non è davvero così.
L’imprevedibilità non ci piace, ci fa paura e questo è molto umano. Altrettanto umana è, però, l’imprevedibilità stessa. Che può farci sentire asincroni rispetto al mondo.
Penso che questa asincronia sia un po’ di tutti, un laghetto che può essere più o meno esteso nei meandri della nostra città invisibile. Un laghetto dove quelle paperelle di preziosi consigli di vita non ci sembrano fatte altro che di gomma e dove ci sentiamo isola, spesso. Soli, nel nostro tempo.
Penso si senta così anche Millie, in “La nuova me” di Halle Butler — quel libro che, vi raccontavo nella scorsa newsletter, mi stava aspettando sul comodino e mi aveva “rapito per la copertina e conquistato per la trama”.
Millie ha trent’anni “e, come si dice, tutta la vita davanti. Montagne di aspettative e speranze che, al momento, devono fare i conti con” la sua realtà, il suo tempo; oscilla furiosamente tra recriminazioni aspre e pigre illusioni sui mille modi per cambiare le cose, ma “la «nuova Millie» non diventa mai tale, il tempo scorre troppo lento e il tedio incombe, alienante.”
Dissacrante e selvaggiamente ironico, La nuova me è una discesa vertiginosa nella mente di una millennial intrappolata nella consapevolezza di una precarietà che non riguarda piú il lavoro soltanto. È il racconto di una generazione ostaggio del modello occidentale dei «generatori di profitto», giovani donne e uomini «cresciuti guardando agli altri come strumenti o ostacoli» (The New Yorker), che lottano ogni giorno con una mente troppo piena e un cuore troppo vuoto.
Avevo riposto tantissime aspettative su questo libro (“Una 30enne in crisi? Ma sono io!”), ma non mi ha raggiunta come avrei voluto. Colpa mia, perché ho fatto l’errore di non leggere che si tratta di una satira e forse non sono “portata” per questo genere.
Una lente un po’ distorta, ma su una realtà tristemente attuale.
Una ricerca di “una nuova versione di se stessi” che rimane sempre ancorata allo stato mentale, come uno schizzo che si continua a buttar giù senza mai realizzare, mentre ci si sente senza contorni e li si brama, per poter mettere un “punto” e sentirsi saldi. Nello sfondo, una società che si sente “lontana” ed eppure è fatta della stessa sostanza, della stessa ricerca.
Si tenta di cambiarsi per non adeguarsi, di migliorarsi senza porsi domande per non adeguarsi, ma così, tutti, ci adeguiamo alla stessa insoddisfazione.
“[…] cercò di immaginarsi come un pezzo di bambú, flessibile ma forte, ma non funzionava e niente stava andando come aveva pensato.”
Nora, Matilde, Luca, Margherita, Paolo. Millie. Io, te, chissà chi.
Vorrei avere una soluzione per questo sentirsi asincroni. Forse un giorno la troverò, anzi, “forse un giorno capirò”, e ne scriverò in un’altra newsletter.
Nel mentre,
un abbraccio e grazie.
Sensibilandia, di nome e di fatto.
Le parole sono il solo modo che conosco per srotolare i gomitoli che abitano le mie città invisibili: le leggo, le scrivo, le ascolto - e così, sempre, le “sento”.
Sono liquide. In movimento, sempre. Mai relegate a una carta stampata o a una voce. O a una email. Cambiano solo forma, prendendo perfettamente il posto che si trovano davanti, come l’acqua, come i gatti. E per quanto tu possa prevederle, programmarle, sono loro, in realtà, a chiamare te.
La magia è che, per ognuno, questa chiamata può dire qualcosa di diverso.
Vi affido queste parole e vi ringrazio tantissimo di avere scelto di leggerle; magari sosteranno un po’ in voi, o forse no, ma mi piace pensare che, in qualche modo, il loro viaggio continuerà. E, se pensate che possano “dire qualcosa a qualcuno”, sarei felice che le condivideste con quella persona.
Amo il contraddittorio, la dialettica e il “mantello della invisibilità” che ci da internet, spesso, e che ci permette di condividere di più, di aprirci di più e, così, di trovare persone con la nostra stessa sensibilità: se avete voglia di “inviarmi il vostro gufo”, rispondere, condividere qualsiasi cosa, dunque, mi trovate “qui” (o sui social).